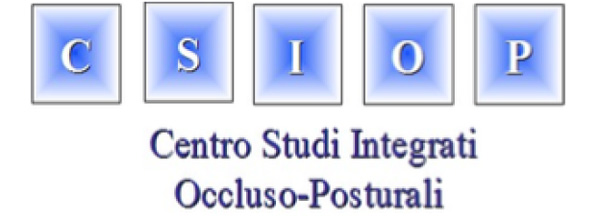LA TESTIMONIANZA. Tina Montinaro, vedova del caposcorta di Giovanni Falcone, al convegno di Prospettiva famiglia
«Mio marito, uomo coraggioso tradito da uno Stato sordo»
All’ingresso del teatro Alcione la carcassa della Fiat Croma, simbolo della strage in cui morirono il giudice, la moglie e tre giovani agenti
Le lamiere accartocciate, ripiegate, straziate: fanno male a guardarle. Ricordano una ferita aperta nel cuore del Paese. La strage di Capaci, con cui la mafia fece saltare in aria il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e i tre giovani agenti della scorta, Antonio Montinaro, Vito Schifani e Rocco Dicillo, risale a 23 anni fa, ma le ombre sulla presunta trattativa Stato-mafia la rendono un simbolo di quella lotta, che non può dirsi vinta.
Le lamiere della Fiat Croma, la Quarto Savona Quindici, esplosa su 400 chili di tritolo il 23 maggio 1992, erano ieri sera esposte in una teca all’ingresso del teatro Alcione. All’interno, sul palco, Tina Montinaro, moglie di Antonio, che da quel giorno continua a lottare perché quelle vite non siano state sacrificate invano. Accanto a lei Gianpaolo Trevisi, direttore della scuola di Polizia di Peschiera, dove viene di solito tenuta la teca con quel che resta della vettura. Quel che resta della memoria lo racconta invece Tina, nell’incontro organizzato dalla rete Prospettiva Famiglia con la parrocchia di Santa Croce, nell’ambito dei progetti di educazione alla legalità.
«Mio marito non era un eroe», dice, «solo un uomo molto coraggioso che credeva nelle istituzioni, che invece non sempre lo hanno protetto». Tina Montinaro non si censura e racconta quella che chiama «antimafia da parata», quei politici che «sul palco ti stringono la mano, ma poi non si fanno mai trovare», le lungaggini che non le hanno ancora permesso di realizzare un Giardino della Memoria nel punto dell’esplosione. «Mio marito faceva presente che non potevano fare sempre la stessa strada, che erano scoperti in autostrada, che sarebbe stato meglio usare un elicottero per portare il giudice in tribunale, ma nessuno gli dava retta, anzi, dicevano che non c’erano i soldi e avevano tolto alla scorta l’indennità di rischio, praticamente proteggevano Falcone da volontari».
Ma nessuno di loro, benché neanche trentenni, con figli piccoli a casa, pensò mai di lasciare. «Non per incoscienza, ma perché ci credevano. Paura? Certo che ne avevano, Antonio sapeva che sarebbe potuto succedere, ma ripeteva che sì, aveva paura, ma non era un vigliacco». Anche dopo l’accaduto Tina è voluta rimanere a Palermo, anche se non era la sua città, «perché tutti dovevano vedere me e i miei figli (di 4 e 1 anno al momento della strage, ndr) e vergognarsi di aver permesso che succedesse». Perché nei ricordi di Tina Montinaro, a Palermo Falcone e la sua scorta davano fastidio. «Dopo che sono morti tutti li amavano, ma in realtà in tanti si lamentavano, avrebbero preferito girarsi dall’altra parte. Dai mafiosi te lo aspetti, ma da chi rappresenta lo Stato no, è ancora più criminale».
È l’atteggiamento mafioso che va combattuto, partendo proprio dell’educazione e dalla scuola. «Se abbassiamo lo sguardo siamo tutti mafiosi», le fa eco Trevisi, «quella macchina è una croce, come quella di Cristo, è il simbolo della lotta del bene contro il male». E la macchina non è stata fermata dal tritolo, corre ancora e con lei le idee di giustizia, di legalità e di libertà.
Elisa Innocenti